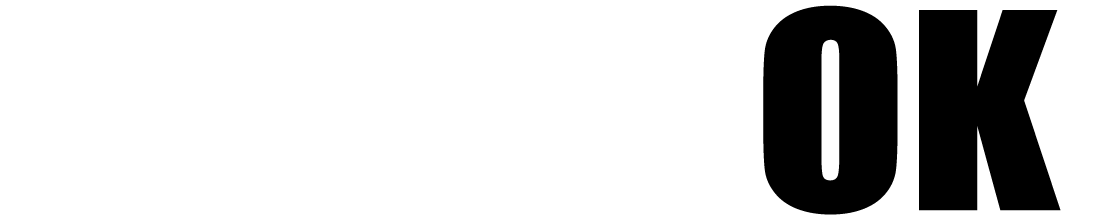L'Autonomia Differenziata è legge, ma siamo certi di sapere di che si tratta?
Nella notte di mercoledì 19 giugno, dopo un lungo esame in aula, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge sulla “autonomia differenziata”, che stabilisce le regole e il...

Nella notte di mercoledì 19 giugno, dopo un lungo esame in aula, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge sulla “autonomia differenziata”, che stabilisce le regole e il percorso con cui alcune regioni potranno chiedere maggiore autonomia nella gestione di specifiche materie.
I favorevoli alla legge sostengono che concedere maggiore autonomia alle regioni permetterà di migliorare i servizi per i cittadini e renderà la spesa delle regioni più efficiente; i contrari, invece, sostengono che concedere maggiore autonomia alle regioni aumenterà le disuguaglianze tra i territori e peggiorerà i servizi già carenti in alcune regioni.
Le posizioni, comunque, sono più complicate di così: basti pensare che alcuni partiti sono in linea di principio favorevoli a concedere maggiore autonomia alle Regioni, ma non seguendo le regole decise dall’attuale governo.
La nuova legge
Il rapporto e la divisione dei poteri tra lo Stato e le regioni sono piuttosto complessi. L’articolo 117 della Costituzione stabilisce che lo Stato, e quindi il governo centrale, ha il potere esclusivo di legiferare – ossia di fare le leggi – su 16 materie, dalla politica estera all’immigrazione. Il potere di fare leggi su altre 20 materie è invece definito “concorrente” dalla Costituzione: come suggerisce il nome, questo significa che sia le regioni sia lo Stato possono legiferare sullo stesso ambito. Tra le materie di competenza “concorrente” ci sono la tutela della salute, la valorizzazione dei beni culturali e la protezione civile. L’articolo 117 aggiunge poi che alle regioni spetta il potere di fare le leggi su tutte quelle materie che non sono di competenza «espressamente riservata» allo Stato.
La nuova legge definisce (art. 1) i «principi generali» da seguire per assegnare maggiore autonomia alle regioni che ne fanno richiesta, nel rispetto del già citato articolo 116 della Costituzione. In più, fissa la procedura con cui dovranno essere approvate le eventuali intese tra lo Stato e le regioni che vogliono più autonomia su alcune materie.
Il nodo dei livelli essenziali delle prestazioni
La nuova legge stabilisce che alle regioni può essere concessa maggiore autonomia solo dopo che siano stati determinati i cosiddetti “livelli essenziali delle prestazioni”, un’espressione spesso abbreviata con la sigla “LEP”. Tra i LEP, spiega la Costituzione, rientrano tutti quei «diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Entro due anni dall’entrata in vigore della nuova legge, il governo dovrà stabilire i LEP con uno o più decreti legislativi. Nel determinare i LEP, il governo dovrà seguire i principi e i criteri fissati dalla prima legge di Bilancio del governo Meloni, quella per il 2023, approvata alla fine del 2022. Questa legge di Bilancio ha istituito la “Cabina di regia per la determinazione dei LEP”, presieduta dal presidente del Consiglio e composta da alcuni ministri.
la nuova legge sull’autonomia differenziata approvata dalla Camera stabilisce (art. 4) che alle regioni può essere concessa maggiore autonomia se non ci siano maggiori costi a carico dello Stato.
Autonomia si, ma a a tempo determinato
Ora che la nuova legge sull’autonomia differenziata è stata approvata definitivamente, non significa automaticamente che le regioni che lo vorranno avranno subito maggiori poteri nella gestione di materie a loro piacimento. Come abbiamo anticipato, la Costituzione prevede che le regioni che vogliono più autonomia devono trovare un’intesa con lo Stato. E la legge approvata dal Parlamento stabilisce (art. 2) appunto il procedimento da seguire per approvare queste intese.
Come prima cosa, le regioni a statuto ordinario che vogliono più autonomia devono deliberare la richiesta da presentare al governo centrale. In seguito questa richiesta deve essere presentata al presidente del Consiglio e al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, che ha il compito di avviare le trattative con le singole regioni. Il negoziato inizia al più tardi dopo due mesi e dopo che i ministeri competenti nelle materie su cui è richiesta maggiore autonomia hanno espresso le loro valutazioni.
L’intesa tra una regione e lo Stato non ha una scadenza indefinita nel tempo. La legge approvata dal Parlamento, infatti, stabilisce (art. 7) che negli accordi dovrà essere specificata la durata dell’intesa, che in ogni caso non potrà essere superiore ai dieci anni.
li stessi accordi, una volta approvati, potranno comunque essere modificati o cessati prima della loro scadenza. Se vorrà rinnovare l’accordo, la regione dovrà fare richiesta allo Stato dodici mesi prima della sua scadenza.
Cinque Regioni contro la Legge
In questi giorni, intanto Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Campania e Sardegna si schierano in prima fila contro la legge sull’Autonomia Differenziata.
Le Regioni, tutte di centrosinistra, stanno studiando la modalità per avanzare ufficialmente la richiesta di referendum abrogativo e preparare il quesito referendario e in questo modo opporsi alla legge approvata dal centrodestra.
Il Veneto si è già messo in moto
Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è stato il primo a muoversi sulla riforma, e ha chiesto l’autonomia differenziata per il Veneto in nove materie non legate ai Livelli essenziali delle prestazioni, per esempio Commercio con l’estero, Professioni, Protezione civile, Previdenza complementare e integrativa e Organizzazione della giustizia di pace.
 12.4°
12.4°